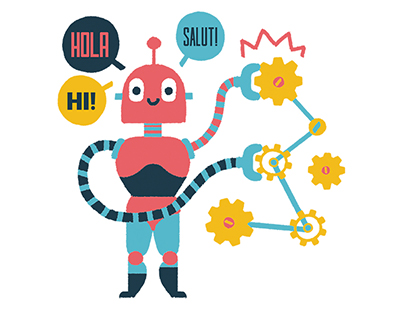Dalla pedagogia per stranieri al multiculturalismo
Concettualizzare il rapporto tra autoctoni e stranieri è impresa complessa con cui da millenni l'Occidente fa i conti1. Nella nostra contemporaneità, un primo modo con cui abbiamo affrontato questo tema/problema è stato quello dell'assimilazione. Il termine, derivando dal latino ad + similis, indica il rendere simile a sé, e rimanda alla metafora biologica dell'incorporazione del cibo che - una volta assimilato, appunto - diventa parte integrante del corpo, costituendo cellule uguali a quelle preesistenti. Questo modello risultava però incentrato sul superamento di un «difetto» dello straniero, di una mancanza da colmare, di una differenza da fagocitare, ed esprimeva una concezione asimmetrica che svalutava l'Altro da assimilare nel Noi della maggioranza. In tale panorama - che ha prodotto una «pedagogia per stranieri» - unico modo per rapportarci all'alterità era che questa semplicemente smettesse di essere tale e sentisse, pensasse e vivesse come noi.
A questo modello teorico è seguito un altro, che riconosce la pluralità delle culture esistenti sul pianeta e le guarda con uno sguardo relativista che ha fatto tesoro della rivoluzione antropologica del concetto di cultura ma che, al contempo, anestetizza tale rivoluzione attraverso la rappresentazione della distinzione tra etnie o culture intese come oggetti coesi, omogenei e discreti. Per questo secondo modello - il multiculturalismo - ogni cultura è un cosmo concluso, originale, incomparabile, e la differenza culturale costituisce un valore da preservare, ma anche da sottrarre a ogni mutamento.
Al multiculturalismo (che costituisce certo un ambito molto variegato) sono state mosse tre critiche principali. La prima afferma che, se il multiculturalismo valorizza l'importanza delle minoranze (a differenza del modello dell'assimilazione, che favoriva il Noi della cultura dominante), lo fa - però - a costo di una tendenziale «museificazione» delle differenze: afferma sì la pluralità del mosaico delle culture, ma tiene sostanzialmente in ombra il piano dell'incontro, del dialogo, dello scambio tra le varie «tessere» culturali2.
La seconda critica denuncia poi il fatto che, all'interno del multiculturalismo, la differenza appare «addomesticata», spesso ridotta a manifestazione folkloristica e inquadrata all'interno di un modello di «tolleranza», intesa a senso unico3. Ricaduta di tale impostazione nelle nostre scuole è stata in passato, per fare solo un esempio, la realizzazione di una festa multietnica dove mangiare il cous-cous preparato dalla mamma di una studentessa maghrebina, dopo un intero anno scolastico pensato solo per gli autoctoni, tanto sul piano dei contenuti disciplinari quanto su quello dell'organizzazione scolastica, così come nella quotidiana pratica relazionale.
Una terza critica che si può muovere al pluralismo multiculturale è, poi, il suo disinteresse per le valenze politiche che la differenza si porta dietro, e la mancata teorizzazione delle asimmetrie di potere che insistono sull'incontro tra le culture. La logica distributiva del multiculturalismo, per fare un esempio concreto, ritiene che, se l'1,5% della popolazione in Gran Bretagna è di origine pakistana, sarebbe giusto che ogni classe sociale, ogni ambito lavorativo, ogni livello di scolarizzazione, contenesse una percentuale dell'1,5% di persone di origine pakistana. Non è invece capace di chiedersi perché la distribuzione di autoctoni e immigrati sia così disomogenea nelle varie classi sociali4. Esemplificazione paradigmatica di tale impostazione è l'enfasi teorica posta su un concetto di integrazione che non tiene conto del fatto che per gli stranieri «la propensione all'integrazione è tanto più elevata quanto più alta è la collocazione dei membri del gruppo all'interno della stratificazione sociale; viceversa è tanto più bassa quanto più numerosa è la presenza di soggetti appartenenti agli strati sociali inferiori»5. L'integrazione, infatti, lungi dall'essere effetto di una «propensione» individuale da favorire con un intervento educatico multiculturale, appare essere una variabile del grado di ricchezza economica, culturale e sociale cui i membri dei gruppi minoritari hanno accesso6.
Pur sostenendo la condivisibilità di tali critiche, è però importante ricordare che le politiche di giustizia multiculturale hanno prodotto un importante effetto: come afferma Kymlicka, infatti, «il rispetto e il riconoscimento dell'identità di una minoranza facilitano l'adozione di identità doppie e complementari che connettono minoranza e maggioranza»7. Non sembra così essersi pienamente av verato - nelle società fondate su un approccio multiculturale - il timore di un mosaico di identità non comunicanti tra di loro e, al loro interno, fortemente omogeneizzanti8. Anzi, il riconoscimento del pluralismo delle identità risulta favorire relazioni più rispettose tra di esse.
L'intercultura
Oggi, il modello che presiede, per lo più, al rapporto con gli stranieri è rappresentato dal vasto e articolato piano dell'intercultura, orizzonte che tende a de-essenzializzare le differenze, a celebrare l'ibridazione culturale, a concepire la cultura stessa come prodotto di un meticciamento.
L'intercultura riconosce infatti, innanzitutto, che non possiamo ridurre l'identità personale all'appartenenza a questo o a quel gruppo culturale. La totale affermazione di appartenenza al gruppo di origine manifesta infatti una condizione di dipendenza la quale - assieme al suo contraltare, la radicale negazione della propria identità di gruppo - impedisce ai soggetti una consapevolezza riflessiva di sé e il riconoscimento dell'identità come scelta e come effetto di un'identificazione o, meglio, di più identificazioni9.
Nel quadro interculturale, invece, identità e culture vengono analizzate in quanto processi performativi e di ibridazione, sottolineando le possibilità di meticciamento culturale, sincretismo religioso, creolizzazione linguistica che si realizzano nelle società complesse10.
Tale rif lessione sulla processualità e sulla performatività dell'identità culturale conduce a una descrizione della cultura - di ogni cultura - come effetto di pratiche di ibridazione. Una cultura si definisce infatti, innanzitutto, come organizzazione delle differenze interne, come «organizzazione della diversità, dell'eterogeneità inerente ad ogni società umana»11. Inoltre, il dialogo tra differenti culture non è successivo alla fase di strutturazione di una cultura, ma sta all'origine stessa del suo processo di strutturazione. Rispetto al multiculturalismo, infatti, l'intercultura riconosce i processi di diversificazione e di unificazione culturale che da sempre accompagnano la storia umana12 - prodottisi attraverso il passaggio degli eserciti, i commerci, le migrazioni, le (tele)comunicazioni, il proselitismo religioso, la disseminazione artistica, la traduzione linguistica etc.13 - e sottolinea, inoltre, l'esperienza del nomadismo transculturale e la strutturazione di appartenenze multiple come condizioni ubiquitarie della nostra contemporaneità.
Nonostante le grandi innovazioni teoriche elaborate dall'intercultura, anche in questo caso rischia di passare in secondo piano la politicità della questione del contatto tra le differenze. L'intercultura può, infatti, ridursi a stucchevole celebrazione della differenza, a ottimistica speranza nelle magnifiche sorti e progressive della società multiculturale, a parenetico invito al meticciamento, mentre andrebbe inquadrata in una cornice politicamente consapevole delle asimmetrie di potere, reddito e accesso alla cultura, che caratterizzano la nostra realtà, nonché della storia di violenze, dominio e negazione dell'Altro all'interno della quale si pone l'incontro con lo straniero.
Un altro non-detto dell'intercultura riguarda poi, specificamente, il suo versante pedagogico. Essa, per lo più, insiste infatti su un piano di universalismo educativo (criteriato in ultima analisi, ma senza alcuna consapevolezza riflessiva, in senso etnocentrico e occidentale) che, di fatto, risulta non rispettoso delle differenze e che, in più, fornisce un mascherato sostegno al mantenimento dello status quo nei rapporti tra autoctoni e alloctoni14. Tale universalismo è particolarmente insidioso perché ottunde la capacità di reazione degli oppressi contro le disuguaglianze e le ingiustizie. Bisognerebbe invece «combattere le discriminazioni strutturali che operano implicitamente nei sistemi educativi e nelle istituzioni dei paesi occidentali»15. Si tratta infatti di abbandonare una concezione falsamente neutrale dell'insegnamento (e dei contenuti, dei valori e dei modelli culturali veicolati) affermando al contempo un impegno etico alla lotta contro ogni forma di dominio che limiti l'emancipazione individuale e di gruppo. Ciò significa che l'intercultura dovrebbe spostare la sua attenzione dal solo livello cognitivo-culturale «a quello politico dei rapporti di forza e del potere sociale»16. La pedagogia interculturale deve cioè confrontarsi col fatto che «il suo progetto non potrà mai realizzarsi nel chiuso delle istituzioni educative perché è fortemente condizionato e interconnesso con le molteplici condizioni socio-economiche e politiche che ne costituiscono la precondizione necessaria»17.
Fin qui ho descritto (semplificando moltissimo correnti teoriche molto differenziate al loro interno) il lungo e ricco percorso teorico che - tra luci e ombre, dalla pedagogia per stranieri all'intercultura - la riflessione educativa ha compiuto nell'appassionato tentativo di confrontarsi con l'alterità e di costruire, per via educativa, una società plurale e maggiormente inclusiva18. A mio avviso, questa tradizione deve però oggi confrontarsi con cinque grandi sfide che una realtà in costante trasformazione le pone; sfide che hanno un nesso più o meno im-mediato con quella condizione postcoloniale che mi accingo a descrivere e che spingono in direzione di un profondo ripensamento dell'intercultura.
Prima sfida. Durante, dopo e attraverso l'esperienza coloniale
Una sfida per l'intercultura è il ritorno nel dibattito teorico attuale del nostro passato coloniale rimosso. Con nostro mi riferisco all'Europa intera, al fatto che senza il loro impero estremamente vasto e redditizio, i Paesi Bassi o il Belgio - ad esempio - sarebbero oggi poco più che piccole, insignificanti democrazie19. Oltre a questi due Paesi, com'è noto, si sono impegnati nell'av ventura coloniale anche - e con grande slancio - il Regno Unito, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Germania, l'Italia e persino la Danimarca. Tanto che, ricorda Said, nel 1914 l'imperialismo europeo controllava sotto varie forme (protettorati, possedimenti, domini, commonwealth, etc.) circa l'85% della superficie terrestre20. Questi semplici dati pongono il colonialismo alle radici stesse dell'identità europea, lo definiscono come parte del nostro DNA storico-culturale21. Il colonialismo è allora un'esperienza che costringe a ripensare la nostra identità europea come cosmopolita e meticcia: non oggi, a seguito delle migrazioni transnazionali, ma già nel processo di formazione delle singole identità nazionali22.
La fase del colonialismo storico si è conclusa quando, verso la metà del secolo scorso, su impulso delle lotte dei popoli colonizzati, si realizza (e nell'arco di soli trent'anni) un vasto processo di decolonizzazione. Questo passaggio non segna però la fine dello sfruttamento europeo delle colonie ma solo una trasformazione di tale abuso, che diventa ora neocoloniale e si basa sui processi di globalizzazione economica. Secondo Betts esiste infatti un collegamento tra fine del colonialismo storico e nascita dei fenomeni di globalizzazione economica: mentre gli imperi si decolonizzavano, le economie acceleravano e innovavano il loro globalizzarsi. Come data simbolo di questo passaggio possiamo usare il 1957, l'anno in cui il Ghana diviene indipendente e, contemporaneamente, viene inaugurato il primo collegamento aereo di linea tra New York e Londra, tra Wall Street e la City23.
L'orizzonte della globalizzazione neoliberista definisce quindi le attuali dinamiche neocoloniali, all'interno delle quali pongo anche lo sfruttamento del lavoro migrante. Infatti, l'attuale «crescita professionale nell'occupazione italiana - con nuovi posti di lavoro tutti non manuali e per lo più qualificati e una riduzione di quelli manuali - trova [ad esempio] un parziale ridimensionamento se facciamo riferimento agli immigrati. Considerando questi ultimi, infatti, la riduzione dell'occupazione manuale non appare così evidente. Gli immigrati fanno in larghissima maggioranza lavori manuali, dequalificati e servili, e questo ha consentito agli italiani di accedere a posizioni di lavoro intellettuali e qualificate»24. Questa strutturazione etnoculturale della gerachia sociale produce tanti vantaggi economici e di benessere quotidiano che ci vengono offerti dallo sfruttamento di badanti mai messe in regola, di operai che si sobbarcano lavori usuranti e pericolosi, di commercianti aperti 24 ore al giorno, di tessitori che producono - per due soldi - il made in Italy, di braccianti agricoli che raccolgono in condizioni disumane i nostri prodotti alimentari, delle migranti prostituite sulle nostre strade, e via discorrendo.
Se durante il colonialismo storico gli europei si spostavano nelle colonie per sfruttarvi la forza lavoro servilizzata delle popolazioni colonizzate, sono oggi queste ultime a trasferirsi in Europa, dove la criminalizzazione legislativa dei migranti irregolari, la fragilizzazione dei diritti e un complesso dispositivo discorsivo (che va dalle campagne d'odio di alcuni politici al razzismo quotidiano del comune cittadino) le destinano allo sfruttamento lavorativo e a un'integrazione subalterna. Il blocco della libera circolazione delle persone costituisce quindi, se accettiamo quest'ottica, un blocco - a livello planetario - della mobilità sociale25 e un dispositivo atto a mantenere stabile l'asimmetria di una strutturazione neocoloniale e neoservile.
La letteratura scientifica ha individuato questo panorama - fatto di sfruttamento per via economica (e non più direttamente militare) delle risorse e delle materie prime dei Paesi ex colonizzati, nonché di sfruttamento lavorativo dei migranti - descrivendo una specifica condizione postcoloniale26 che accomuna (con posizionamenti ovviamente diversi) tanto «noi», nati nella metropoli europea, quanto gli «altri», nati nelle colonie.
Tale condizione è da intendersi in due modi. Nel primo modo, quello postcoloniale (col trattino) si cerca di recuperare quel percorso storico che ci hareso quello che siamo. È un processo di costruzione della nostra realtà attuale di cui non ci rendiamo neppure conto, grazie alla rimozione culturale del nostro passato colonialista, la quale è avvenuta certo in tutt'Europa ma in Italia appare particolarmente marcata27. Il processo di decolonizzazione nelle colonie italiane non fu infatti frutto di una lotta anticoloniale, piuttosto effetto della sconfitta del regime fascista centrale, e mancò quindi (e ancora oggi manca) qualunque forma di elaborazione teorica dell'esperienza coloniale. Una mancata consapevolezza che ci è possibile mantenere anche grazie al fatto che i migranti che arrivano oggi in Italia non provengono - per lo più - dalle ex colonie, definendo così un panorama di post-colonialità indiretta28 che rende non immediatamente leggibili ed evidenti quei legami tra colonialismo storico e odierne migrazioni che ho sottolineato sopra. L'uso del termine postcoloniale per definire la nostra condizione ha allora la finalità di denunciare proprio questi legami: serve a evidenziare «la complicità dell'Italia nella storia del colonialismo e del capitalismo a livello mondiale, nonché il ruolo dell'Italia nell'ambito della globalizzazione attuale»29. La nostra condizione è insomma post-coloniale tanto per il fatto che il nostro panorama urbano continua a comprendere (senza scandalo di nessuno) monumenti e nomi di strade che ricordano «vittorie» ed «eroi» del nostro passato coloniale30, quanto per il fatto che continuiamo a stabilire con migranti e postmigranti una relazione che ricorda da vicino - perché di fatto la prosegue senza soluzione di continuità - quella coloniale storica, fatta di sfruttamento, razzismo e negazione dei diritti.
Oltre a tutto ciò, possiamo dire che viviamo anche una seconda condizione postcoloniale (questa volta senza trattino) nel senso che siamo tutti (popoli ex colonizzatori e popoli ex colonizzati) coinvolti in dinamiche di sfruttamento e discriminazione che non rispettano più la contrapposizione tradizionale tra metropoli e colonie, ma che si riproducono all'interno del territorio della metropoli europea. Il lavoro migrante tende infatti a sovvertire le regolazioni nazionali del mercato del lavoro (economiche, sindacali e politiche), amplificando la visibilità dei processi neoliberisti di precarizzazione e fragilizzazione del lavoro per tutti i lavoratori31.
Schematizzando, possiamo dire che esisteva una contrapposizione tra il territorio dei colonizzatori che sfruttavano (la metropoli europea) e il territorio della colonia, dove i colonizzati venivano sfruttati, ma che tale contrapposizione è ormai collassata, per il fatto che i popoli coloniali da sfruttare vivono (e vengono sfruttati) dentro la vecchia metropoli. A questa contrapposizione ne corrispondeva un'altra, quella tra colonizzatori europei e colonizzati extra-europei, che è- anch'essa - collassata, dato che la relazione di sfruttamento coloniale appare oggi opprimere pienamente tanto gli ex colonizzati quanto i discendenti dei colonialisti europei, strutturando - per alcuni analisti - relazioni di lavoro neoservile32 e di accumulazione per espropriazione33 che attraversano la vecchia contrapposizione coloniale. Ecco perché, per un antropologo come Lanternari, la condizione postcoloniale è descritta dalla lotta politica dei gruppi egemoni tanto contro i popoli delle colonie quanto contro i gruppi subalterni della madrepatria34.
La comune condizione tra i diversi gruppi subalterni non può però creare un'allenza politica. Il colonialismo, infatti, è stato (ed è) anche una relazione di egemonia culturale, che struttura le coscienze, creando soggettività differenti. All'interno di questo dispositivo, gli ex colonizzatori sono soggetti a una forma di violenza epistemica che li conduce a ritenere naturale il proprio dominio sugli ex colonizzati. In questo inquadramento sono poi inevitabilmente presi anche gli immigrati che - avendo sperimentato la disillusione per il fallimento delle rivoluzioni anti-coloniali e uno sfrenato sfruttamento neocoloniale - possono avere interiorizzato un'asimmetria ammirata e servile nei riguardi degli europei o, al contrario, aver sviluppato un orizzonte mentale di critica dipendente e di vincolante insubordinazione35. La relazione egemonica postcoloniale assoggetta insomma (ex) colonialisti ed (ex) colonizzati all'interno di un medesimo schema epistemico che induce forme di rappresentazione dei secondi funzionali all'esercizio del dominio da parte dei primi36. Tale schema epistemico continua a riprodursi in maniera inesausta attraverso rappresentazioni e pratiche quotidiane che creano una gerachia di valore tra identità razzializzate, defininendo così la condizione postcoloniale di tutti.
Ricapitolando quanto detto, la lente post-coloniale serve a rileggere il nostro passato colonialista e a comprendere tale pesante eredità che, attraverso la globalizzazione e il neocolonialismo, condiziona ancora il nostro presente socioeconomico. L'ottica postcoloniale, invece, serve a comprendere la nostra sottomissione a dispositivi di sfruttamento economico e assoggettamento simbolico che si abbattono, con - è bene ricordarlo sempre - posizionamenti diversi e asimmetrici, tanto sui soggetti «metropolitani» quanto su quelli «coloniali».
È però evidente che esiste una forte embricatura tra le due accezioni, la quale rende possibile distinguerle solo a livello teorico, e che consente invece di usare - come farò da ora in poi - il solo termine postcoloniale per riferirsi a uno strumento di analisi teorica articolato ma unitario.
Quanto detto, secondo me, sfida teoricamente l'intercultura, la mette sotto pressione, forse la trasforma. Come si pone infatti essa rispetto alle dinamiche postcoloniali descritte? Come può incidere su questa complessa condizione? Cosa è capace di dire?
Seconda sfida. L'italianità: sbiancata, razziale, postrazziale
Un'altra sfida posta all'intercultura è rappresentata dal legame - impensato e non tematizzabile - che esiste tra l'impresa coloniale e le migrazioni di quei ventisette milioni di persone che, tra il 1876 e il 1976, lasciarono l'Italia per disperdersi in tutti e cinque i continenti37. Durante questa lunga migrazione, gli italiani furono vittime del razzismo e delle molte violenze a esso collegate38. Importante ai nostri fini è, soprattutto, il fatto che gli emigranti italiani non sempre fossero considerati bianchi!
Il loro sfruttamento lavorativo, ad esempio negli USA, era infatti sorretto dalla negazione di fatto della loro whiteness, che i nostri migranti dovettero (ri)costruire39. In cento anni la pelle degli italiani non può aver subito modificazioni cromatiche ma, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, gli italiani - che avevano lo stesso «colore» (forse al plurale) che hanno oggi - non erano considerati «bianchi», specialmente se meridionali. Questo fatto conduce all'ov via constatazione che bianco, se riferito alla pelle degli esseri umani, non indica un colore, ma una costruzione socioculturale, un sistema di privilegi, l'effetto di pratiche di alterizzazione dell'Altro tese al suo sfruttamento e alla sua marginalizzazione. Nello stesso periodo, il colore della pelle era infatti usato anche dalla retorica politica nostrana, per sostenere simbolicamente la contrapposizione degli italiani ai popoli delle colonie.
L'emigrazione degli italiani e la colonizzazione dell'Africa sono da analizzare poi come fenomeni correlati perché originati dalla medesima necessità, dello Stato italiano, di stabilire reti economiche transnazionali a supporto della sua giovane economia nazionale40. Ne è un esempio paradigmatico il fatto che, nell'Italia postunitaria, il governo di Crispi considerava e definiva colonie tanto gli insediamenti di emigranti all'estero quanto i possedimenti dell'Africa orientale41.
Tener conto di questo collegamento permette di ricordarci che, fatta l'Italia, bisognava ancora fare gli italiani, anche dal punto di vista dell'identità etnoculturale. Tale processo si è, così, faticosamente strutturato - secondo Welch - nell'intersezione tra la questione meridionale, l'emigrazione e il colonialismo (liberale prima e fascista poi)42.
Il colonialismo italiano era innanzitutto sorretto da considerazioni svalutanti e razziste nei confronti dei colonizzati. E la letteratura italiana - dall'Unità in poi - definiva il suo canone nazionale anche attraverso opere dalla forte impronta orientalista e africanista: da Serao a D'Annunzio, da Carducci a Pascoli, da Marinetti a De Amicis, da Ungaretti a Flaiano43. In questo complesso meccanismo la posta in gioco era, ricordiamolo, anche la nostra whiteness, e da esso dipendeva anche la condizione esistenziale dei nostri connazionali emigrati.
Quello esterno si affiancava poi al colonialismo interno, che riguardò - com'è noto - il nostro Mezzogiorno44. Anche quello interno, come ogni colonialismo, era razzista e antropologi positivisti come Lombroso e Ferri ritenevano, com'è noto, i meridionali membri di una razza diversa da quella degli italiani del Nord, di origine africana e maggiormente incline alla criminalità e al vagabondaggio. Possiamo allora leggere quello che ha riguardato il Meridione come un unico processo coloniale che va dall'annessione dello stato borbonico alla lotta al cosiddetto «brigantaggio», fino alla dura condizione dei «terroni» emigrati al Nord. Un processo che, come tutti quelli coloniali, continua ancora oggi attraverso l'emigrazione dei meridionali, fenomeno che non si è mai interrotto e che trova anzi oggi nuova vitalità45. Tali considerazioni confermano, se ce ne fosse bisogno, la contrapposizione tra nazioni colonizzatrici e popoli colonizzati come ideologica e ingannevole.
La continuità e la contiguità tra colonizzazioni e migrazioni fa insomma parte della storia del nostro Paese prima delle aggressioni coloniali in Africa e ben prima dell'attuale immigrazione internazionale. Dimentichi dell'emigrazione italiana all'estero, del nostro non essere stati considerati bianchi e della colonizzazione interna ed esterna, abbiamo però ormai raggiunto una consapevolezza etnoculturale nella quale la normatività della nostra identità nazionale (fondata - durante il fascismo - esplicitamente sulla razza e su una bianchezza da contrapporre alla Faccetta nera) agisce in maniera implicita e invisibile46. La nostra ormai conquistata whiteness non è però più esplicitamente associabile - in Europa, ma non ad esempio negli USA - a una parola come razza, ormai andata in disuso come categoria teoricocritica47. Viviamo infatti in una società in cui la razza non è certo scomparsa come forma di categorizzazione identitaria usata quotidianamente (né è ovviamente scomparso il razzismo), ma in cui le categorie razziali operano in modo nuovo, più nascosto e scarsamente analizzato.
La tragedia della Shoah ha infatti condizionato fortemente i discorsi europei sul razzismo, oscurando il colonialismo e le migrazioni come elemento centrale della storia del razzismo europeo48. Ciò permette, ad esempio, agli Stati europei di celebrare (giustamente) la Giornata della memoria e, contemporaneamente, di escludere i migranti dai diritti di cittadinanza, di sfruttarli lavorativamente, di segregarli dal punto di vista abitativo, di denigrarli e criminalizzarli. Ci permette di festeggiare l'anniversario della caduta del muro di Berlino in un'Europa che si struttura ogni giorno di più come una fortezza e dove proliferano i muri (materiali e immateriali) destinati a contenere gli stranieri.
Quest'analisi dei legami tra colonialismo e razzismo, tra bianchezza della pelle e atteggiamenti e politiche antimeridionali, tra emigranti italiani e immigrati provenienti dalle ex colonie dell'Europa, porta a considerare l'identità italiana come effetto di una costruzione, risultato di pratiche discorsive e materiali transnazionali che avevano origine anche oltre i confini nazionali, e che continuano a essere strutturate dagli eventi globali a noi contemporanei. L'italianità risulta cioè frutto di tre dinamiche storiche (colonialismo interno, colonizzazione dell'Africa ed emigrazione) che sono oggi semplicemente evidenziate dalle recenti immigrazioni, le quali fanno solo risaltare la nostra postcolonialità.
Quest'ottica sfida l'impostazione interculturale, che si focalizza sulla relazione tra le culture, utilizzate come punto di partenza. Cosa succede all'intercultura se si mette in questione la stessa identità italiana? Inoltre, può la pedagogia interculturale, con la sua forte impronta culturalista, tollerare la reintroduzione di categorie «razziali» e «materialiste» come strumenti teorici finalizzati alla critica politica delle concrete relazioni tra autoctoni e alloctoni?
Terza sfida. La creatività culturale (di noi e degli altri)
Ancora una sfida all'intercultura è rappresentata dalla recente trasformazione dei movimenti migratori. Siamo infatti passati da quelli internazionali ai movimenti transnazionali49. Lo spostamento, innanzitutto, non è compiuto dalla gente una volta e per tutte, ma può prevedere successive migrazioni lavorative, matrimoni o percorsi formativi transnazionali, nonché viaggi e rientri (più o meno definitivi) in madrepatria. Non si ha quindi un passaggio semplice e unidirezionale da un Paese a un altro, ma la creazione di campi - economici, politici, sociali e culturali - che comprendono tanto il primo quanto il secondo Paese, rendendo critico un concetto come appartenenza e superato quello di integrazione, sostituendo alla coppia madrepatria / società di destinazione il concetto di network transnazionale. Si tratta insomma di movimenti di popolazioni - dai tamil ai cinesi - che non sono più comprensibili attraverso una cornice teorica centrata sullo stato-nazione, e che - specialmente nel caso delle diaspore - costringono l'intercultura a pensare non più in termini di contatto tra due culture, ma a utilizzare un modello complesso che comprenda (almeno) tre poli in continua interazione: il Paese di destinazione, le comunità che vi si istallano (mantenendo spesso un'autonomia simbolica e, a volte, anche economica e commerciale) e la madrepatria da cui queste ultime provengono50. Questa strutturazione transnazionale e diasporica è a mio av viso leggibile solo dentro una cornice postcoloniale, sia perché le diaspore sono spesso l'onda lunga del colonialismo storico51, sia in quel più vasto senso culturale che definisce la nostra contemporaneità, condizionando i processi di soggettivazione e tendendo a trasformare il concetto stesso di identità nazionale. La presenza di soggetti diasporici nelle nostre città porta inoltre con sè - secondo Portelli - una nuova questione teorica: vengono da tutto il mondo, ma vengono tutti nello stesso posto, e allora «al concetto di diaspora (dispersione da un'origine comune) dovremmo affiancare un concetto che, in attesa di una parola migliore, chiamerei di convergenza (punto di arrivo comune da origini diverse). La convergenza svuota di senso il concetto di "autenticità'»52. La convergenza transnazionale verso l'Europa mette ancora di più sotto stress l'idea di un'autenticità culturale che, se nel paragrafo precedente abbiamo definito costruita nella relazione con l'Alterità (entro uno spettro di matrice coloniale), dobbiamo ora descrivere come ancora in costruzione: sempre più, sempre più velocemente e in forme sempre più inedite.
Questo cambio di ottica non è però frutto solo di una pressione migratoria transnazionale ma anche effetto di cause endogene. La costruzione ottocentesca dello stato-nazione prevedeva infatti la formazione della propria popolazione, attraverso l'istruzione obbligatoria, la sanità pubblica, l'estensione progressiva dei diritti, la tendenziale inclusività sulla base della cittadinanza, etc. A seguito delle migrazioni di massa, gli Stati europei hanno però progres sivamente smesso di formare la popolazione, limitandosi a selezionarla53. Lo Stato neoliberista, cioè, non «costruisce» più tanto cittadini omogeneizzati e disciplinati nell'uso dei diritti, ma li seleziona tra i migranti. Insomma, «il venir meno della convinzione che la popolazione sia una risorsa data che va presa in carico e curata per aumentare la forza dello Stato, spinge dunque verso una società in cui la politica smette di prendere in carico i soggetti sia singolarmente che collettivamente, di conferire loro un'identità, di dedicarsi a, o di predisporre l'ambiente per, la loro trasformazione: viene meno la costruzione della 'nazione'»54.
A questa duplice sfida - interna ed esterna - lanciata alla tradizionale sovrapposizione tra nazione e cultura corrisponde una rinnovata creatività culturale, evidentissima nelle nostre società. Assistiamo infatti a processi di frammentazione e - insieme - di integrazione delle identità, i quali creano continuamente gruppi nuovi e mobili. La pluralità sociale è infatti oggi rappresentata, al di là degli stranieri, da gruppi subculturali o controculturali che si differenziano notevolmente e continuamente. La cultura italiana si è talmente pluralizzata e differenziata al suo interno che per un anziano contadino di Canicattì - ad esempio - la distanza culturale da un tunisino (che abbia la stessa età e lo stesso lavoro) può risultare minore di quella che lo separa dalla giovane punkabestia lesbica di Milano, sebbene tanto i canicattinesi quanto i milanesi siano italiani. Purtroppo, però, la nostra attenzione si rivolge ancora prevalentemente ai rapporti tra le culture (cioè agli aspetti interculturali), trascurando il piano intraculturale55.
In questo panorama, la creatività culturale che ne risulta non è individuale, ma costituisce una continua produzione e riproduzione di identità attraverso processi intersoggettivi e intergruppali. Ov viamente, ogni identità culturale si dà sempre all'interno di campi di forze e di rapporti di potere, ma questa condizione di fluida e ribollente creatività potrebbe trasformare e complessificare l'opposizione dicotomica noi/altri, egemoni/egemonizzati56, cioè - nella nostra ottica - la contrapposizione tra (ex) colonizzatori ed (ex) colonizzati.
Con creatività mi riferisco non solo e non tanto a forme di meticciamento (anche se certo le comprendo nel mio orizzonte) ma a modi di relazione e condivisione che relativizzano (anche se non cancellano) le identità ereditate57. Se questa ipotesi di un'accelerata creatività culturale è plausibile, si pone oggi all'intercultura una nuova sfida educativa: «inventare, costruire, dare vita a forme sociali e culturali nuove, inedite, impreviste, soprattutto in contesti caratterizzati dalla compresenza o convivenza interculturale, anche in presenza di relazioni asimmetriche e coloniali»58. Saprà però l'intercultura dimenticare il prefisso inter iscritto nel suo stesso nome, cessando di porsi tra le culture, per posizionarsi epistemologicamente alla matrice di quella ipercinetica creatività che, oggi, fonda sempre nuove differenze culturali?
Saprà allora l'intercultura leggere i bisogni dei soggetti diasporici (transculturali e non più inter-culturali) e quelli prodotti dalle nuove identificazioni intraculturali (sub-culturali e contro-culturali)?
Quarta sfida. L' intercultura come terreno di lotta e di riconoscimento
L'intercultura nasce come discorso accademico occidentale. Al suo interno, il noi resta sempre, di fatto, il soggetto teorico di ogni analisi, di ogni domanda, di ogni ricerca. Anche quando parliamo dei marocchini, dei nigeriani o degli albanesi, in realtà non smettiamo di parlare di noi e, in questo nostro discorso, il non-occidentale - nota Chakrabarty - non parla nemmeno quando ne riconosciamo l'esistenza59. Secondo de Certeau, infatti, tanto l'antropologia quanto la pedagogia, nel tentativo stesso di comprendere l'Altro, lo modellano di fatto, articolando un sapere sul suo silenzio60. Insomma, mai arriva a noi la voce dell'Altro, soltanto l'immagine che ne costruiamo, in un rispecchiamento in cui l'autoctono replica il proprio sapere mentre plasma la forma del migrante61. La conoscenza dell'Altro si risolve così in una «parola istituita in luogo dell'altro»62, destinata a realizzare «un ritorno da sé a sé attraverso la mediazione dell'altro»63. La teorizzazione interculturale è cioè sostanzialmente interna al soggetto occidentale, opera di ricercatori anche progressisti e benintenzionati ma sicuramente bianchi, autoctoni, abbondantemente scolarizzati, di ceto medio, che non hanno mai dovuto affrontare l'esperienza della migrazione e - soprattutto - nati, socializzati e soggettivatisi in Paesi ex/neo colonialisti64.
Ciò, è evidente, pone un problema di etica della ricerca nonché di democrazia della relazione politica. Oliverio sottolinea infatti come la legittimità di ogni decisione democratica dipenda dal grado in cui coloro che ne sono interessati sono inclusi nei processi di deliberazione e ne possono inf luenzare gli esiti65. Il piano interculturale (in quanto impostazione esclusivamente occidentale) pone allora - e immediatamente - un problema di democrazia.
L'assenza della voce del migrante, tanto nella ricerca scientifica quanto nella deliberazione politica che - entrambe - lo riguardano direttamente, va a mio avviso interpretata all'interno (ancora una volta) di una cornice postcoloniale. Avremo fatto i conti con l'eredità coloniale solo quando finalmente le stesse minoranze conquisteranno la possibilità di dire la loro in materia di educazione e di politiche sociali. La presa di parola contiene infatti in sé una tensione emancipativa che costituiva già l'anima dell'antica democrazia ateniese66 e che oggi ha come campo di dispiegamento le nostre società complesse, dove la presa di parola può implicare il partecipare, consapevolmente ed esplicitamente, alla costruzione del dialogo tra le differenze e, più in generale, alla creazione di una società inclusiva che si lasci alle spalle l'eredità coloniale. La mancata presa di parola da parte degli Altri incide, invece, sulla mancata connotazione interculturale della nostra democrazia67, nonché sulla mancata connotazione democratica della ricerca interculturale. Al contrario, la presa di parola da parte di tutti/e ha in sé una grande potenzialità emancipativa visto che «un subalterno che parla non è più tale», secondo quell'affermazione di Spivak diventata una sorta di slogan degli studi postcoloniali68. La posta in gioco nel nostro mondo postcoloniale è infatti proprio la condizione di subalternità che, secondo d'Adesky, discende genealogicamente da due fenomeni storici - la decolonizzazione e la globalizzazione - che hanno avuto effetti politici, economici e sociali su una pluralità di gruppi, presenti tanto al Nord quanto al Sud del mondo, accomunati da un limitato potere di enunciazione e da un basso livello di reddito69.
I subalterni, però, non accettano passivamente questa situazione, e lottano. Lotte migranti sono portate avanti da soggetti che, dopo aver attraversato i confini, esprimono pratiche di auto-organizzazione e di auto-rappresentazione pubblica tese, secondo Oliveri, anche al divenire soggetti politici di pieno diritto70. Dalle lotte di Nardò a quelle di Rosarno, da Castelvolturno a Pioltello, questi soggetti producono nuove identità, nuove solidarietà, nuove coalizioni (anche tra soggetti di diversa nazionalità) e combattono per la libertà di movimento, per il diritto alla residenza, per i diritti sociali e al lavoro. Conf liggono con quel modello di sfruttamento e di misconoscimento che affonda le sue radici nel colonialismo storico e nella globalizzazione neoliberista che lo ha sostituito. Il nostro mondo postcoloniale risulta, così, fatto di lotta: «lotta di riconoscimento, più che lotta per il riconoscimento, non è per farsi riconoscere in seguito a un misconoscimento, ma è costitutiva del riconoscimento e del rapporto. Il riconoscimento è lotta»71. I migranti creano riconoscimento di sé dentro e attraverso la lotta!
Le lotte dei migranti, opponendosi culturalmente al contenimento e alla criminalizzazione delle migrazioni (insieme a quelle stesse politiche governative che combattono) esprimono infatti una trasformazione del nostro orizzonte politico: «un duplice processo di politicizzazione della cultura e di 'culturalizzazione' della politica: le linee di conflitto nelle società globalizzate vengono sempre più spesso identificate con la diversità etnico-culturale; la produzione simbolico-culturale e la formazione delle identità entrano costitutivamente a far parte del lessico e delle risorse della politica»72.
Accettare questo piano significa riconoscere la qualità costitutivamente conflittuale del rapporto interculturale e, di conseguenza, dover permettere - alle istanze politiche dei migranti, dei subalterni, dei soggetti diasporici e a tutte le differenze in lotta di riconoscimento - di avere voce in capitolo.
La conflittualità del nostro presente interculturale è però oggi rappresentata anche dalla violenza terroristica dispiegatasi nei recenti attentati in Turchia, Francia, Siria, Mali, Nigeria etc. Se i mass media leggono questi avvenimenti (in modo semplicistico e, secondo me, irresponsabile) come espressione di un epocale scontro tra civiltà, quanto abbiamo detto finora può invece spingerci a interpretarli come atti di guerriglia di membri di popolazioni vittime di ormai 150 anni di (neo)colonialismo, i cui sistemi statali sono stati rovesciati dalle democrazie occidentali (lasciandoli spesso nel caos come in Libia e in Iraq), i quali - aizzati da imprenditori armati e sobillati da integralisti religiosi - conducono, con una violenza inaccettabile e indiscriminata, una lotta che vuole affermare una radicale alterità da «noi» e perseguire un ribaltamento dei rapporti di forza. Al fanatismo cieco e alla violenza folle possiamo forse sostituire, come eziologia di quanto accade, anche l'impossibilità delle popolazioni ex colonizzate di influenzare i processi culturali e politici che li riguardano (pensiamo solo alla disperata impotenza dei rifugiati palestinesi nei campi profughi), la continua espropriazione imperialistica delle loro risorse (si pensi, ad esempio, alle imprese europee e statunitensi che attualmente gestiscono l'economia irachena), la continua mancanza di sicurezza che può trasformare in strage un matrimonio o un funerale (come in Afganistan), nonché l'impossibilità di una loro presa di parola che ottenga ascolto (se non attraverso l'uso, mai giustificabile, della violenza).
Leggere come postcoloniali le guerre in Iraq, Somalia, Afganistan, di nuovo in Iraq, e in Libia, la nostra alleanza con Stati che fomentano il terrorismo (come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Israele ed Eritrea), i commerci di armi e petrolio che ci legano all'Isis e la condizione di oppressione materiale e morale imposta a tantissimi giovani razzializzati (a Tunisi, a Il Cairo o nelle banlieues occidentali)73, permette forse di darci strumenti analitici più raffinati e di ricondurre questi avvenimenti all'interno del più vasto campo dei problematici rapporti interculturali, da intendere come ambito di conflittualità postcoloniale: dinamica e creativa nel caso delle lotte dei migranti o sclerotizzata e mortifera nel caso dei terroristi.
Può, però, l'intercultura confrontarsi con la conflittualità, superando quel modello irenico di ricomposizione e di integrazione armonica delle differenze che, finora, l'ha caratterizzata?
Quinta sfida. L' intersezionalità e le differenze
Esiste un non-detto di genere nella immaginazione prima e nella costruzione poi della nazione, termine etimologicamente connessa con il verbo nascor, la stessa radice di naturalis, che quindi rimanda all'immagine della nascita e della madre, fondando simbolicamente una naturale autoctonia74 e naturalizzando, in questo modo, quella che è ovviamente una costruzione immaginaria: appunto, la nazione75. Possiamo di conseguenza dire che ogni riferirsi alla nazione come fondamento «è sempre sessuato, anzi è proprio attraverso la sua ideologia, e in suo nome, che diventano operative e funzionali sia le asimmetrie di potere tra i sessi sia quelle tra le cosiddette razze»76. Il corpo femminile è insomma ostaggio della nazione fin dalla sua costruzione e la critica postcoloniale ha messo bene in evidenza il carattere sessista tanto dei nazionalismi quanto delle lotte di liberazione nazionale (nonché sullo stretto legame che c'è tra eterosessualità riproduttiva e nazionalismi)77. È infatti attraverso il controllo della sessualità delle «nostre» donne e la loro inaccessibilità agli stranieri che si fonda, e si mantiene, ogni purezza etnica, si perpetua ogni identità nazionale e si evita ogni contaminazione razziale.
Una specifica costruzione della femminilità è stata centrale anche nei territori coloniali. Già nell'America schiavista (cioè dal 1619) vediamo in atto un legame stretto tra sessismo e razzismo che riconosce nella sessualità femminile una risorsa da sfruttare e che distingue le donne bianche (inaccessibili ai neri) da quelle nere (pienamente accessibili agli uomini bianchi). Anche dopo che l'America cessa di essere una colonia europea (e almeno fino al 1865), sessismo e razzismo vanno di pari passo, utilizzando la doppia arma degli stupri delle nere (che rendevano i neri incapaci di difendere le proprie donne) e del linciaggio, che colpiva gli afroamericani che si ribellavano (o che si non mantenevano a debita distanza dalle bianche) e che, com'è noto, prevedeva anche la loro evirazione78. Non stupisce quindi il fatto che anche le lotte antischiaviste e le più recenti rivendicazioni politiche degli afroamericani abbiano riprodotto una strutturazione sessista e machista, il fatto che - come nota una teorica del femminismo nero come bell hooks - «neri e nere hanno di rado sfidato l'uso delle metafore di genere per descrivere l'impatto del dominio razzista e/o la lotta di liberazione nera. Il discorso della resistenza nera ha quasi sempre identificato libertà e virilità, dominio economico e materiale sui maschi neri e castrazione, evirazione. Accettare tali metafore sessuali ha creato un vincolo tra i maschi neri oppressi e i loro oppressori bianchi. I due gruppi condividono la credenza patriarcale che la lotta rivoluzionaria abbia come proprio vero oggetto l'erezione fallica, la capacità maschile di stabilire un dominio politico equivalente al dominio sessuale»79.
D'altro canto, tutto il colonialismo europeo si è storicamente legittimato attraverso metafore sessuali che femminilizzavano (cioè devirilizzavano) i colonizzati e l'impresa coloniale stessa veniva connotata con immagini che rimandavano all'esplorazione, alla penetrazione, alla conquista, allo stupro di terre «vergini»80. La nostra propaganda coloniale sottolineava esplicitamente le opportunità erotiche, fornite dalle colonie a uomini che vivevano in un'Italia caratterizzata dalle inibizioni sessuali e da una morale tradizionale81. Il colonialismo fu poi, innanzitutto, un affare di uomini: la guerra in Etiopia, ad esempio, coinvolse quasi mezzo milione di giovanissimi italiani, circa uno su cinque dei maschi che nel 1935 avevano tra i venti e i venticinque anni82. Ed effetto del colonialismo furono gli stupri di molte africane, nonché forme di prostituzione coloniale, come lo sciarmuttismo e il madamato83.
All'erotizzazione dell'impresa coloniale si accostò però, durante il fascismo, anche una rappresentazione che differenziava le donne africane, sessualmente sfrenate ma anche maleodoranti e portatrici di malattie, da quelle italiane, madri di famiglia, angeli del focolare, matrici riproduttive al servizio dell'Impero84. Ciò mostra come sessismo e razzismo si rinforzassero vicendevolmente in vista di una normalizzazione e di una gerarchizzazione dei rapporti tra le differenze, tanto nella madrepatria quanto nella colonia. Il dispositivo coloniale non separava, insomma, la gerarchizzazione razziale delle differenze etnoculturali dalla gerarchizzazione sessista di quelle di genere.
L'esperienza coloniale si è però storicamente servita anche di una serie di altre metafore - infantilizzanti (colonizzatori adulti vs. colonizzati bambini), paternalistiche (genitori europei vs. figli colonizzati) o pedagogiche (europei maestri vs. colonizzati allievi) - che rimandavano a una gerarchia dell'obbedienza dei colonizzati verso i colonizzatori85. Ancora, i popoli colonizzati erano considerati mentalmente sottosviluppati e contrapposti alla civiltà e allo sviluppo tecnologico occidentale, oppure bestializzati nei loro istinti, contrapposti a quelli pienamente umani dei colonizzatori. Il fardello dell'uomo bianco si situava cioè - per schematizzare in modo tranchant - a metà tra la fatica del dottor Itard e quella di un allevatore di vacche, colorandosi di connotazioni abiliste e speciste86.
Su queste basi, è diventata cifra dell'ottica postcoloniale un approccio teorico - sempre più condiviso, in Nord America e in Europa, negli ambiti accademici antirazzisti, antisessisti e dei cultural studies - basato sull'intersezionalità. Quest'ultima propone «una visione della differenza come relazione basata simultaneamente su punti di somiglianza e punti di differenziazione. In sostanza, l'intersezionalità mette in dubbio la possibilità di parlare di 'cultura' senza parlare [ad esempio] anche di 'religione' o di 'classe' poiché vede la differenza come qualcosa che agisce contemporaneamente su tutti gli attributi che descrivono un soggetto, per cui non è possibile parlare di una dimensione della diversità senza chiamare in causa anche le altre»87. E l'intersezionalità riesce bene a spiegare l'intreccio di razzismo, femminilizzazione, infantilizzazione, abilismo e specismo che caratterizzava la rappresentazione coloniale dell'alterità.
Com'è noto, l'approccio intersezionale nasce in realtà all'interno del pensiero femminista88 e si è successivamente propagato in quello postcoloniale grazie a quelle studiose che ne hanno elaborato i collegamenti teorici89. Zoletto, tuttavia, sottolinea come i fondatori della critica postcoloniale - Spivak, Said, Mbembe... - intendano la decostruzione del discorso coloniale anche come un investimento in un nuovo umanesimo, critico e cosmopolitico, basato sulla partecipazione di tutti a ciò che ci rende diversi, a una sorta di universalismo meticcio90 che, in maniera ancora più ineludibile, deve allora - a mio avviso - confrontarsi con il piano dell'intersezionalità tra le differenze. Insomma, anche se l'approccio intersezionale non rappresenta la totalità della vasta compagine postcoloniale, ne costituisce tuttavia, a mio avviso, una componente essenziale che, soprattutto, risulta utilissima nel campo interculturale di cui parliamo.
L'ottica intersezionale acquista infatti grande rilevanza nella nostra società attuale, nella quale è importante riconoscere la pluralità di relazioni sociali e di differenze (culturali, di genere, sessualità, età, classe sociale, dis/abilità...) che si attraversano nella concretezza delle esperienze, e che va quindi analizzata non solo attraverso la lente della diversità culturale. Questo approccio implica infatti l'utilizzo della metafora dell'iceberg per descrivere una cultura, distinguendone le componenti oggettive da quelle soggettive: «nella parte emersa vengono poste le dimensioni oggettive, che sono quelle relative ai simboli e alle espressioni artistiche, mentre in quella al di sotto del livello del mare sono elencate le variabili soggettive di una cultura, come le relazioni di genere e di ruolo, gli stili di comunicazione verbale e non verbale, il rapporto con la natura e con gli animali, il senso del tempo e dello spazio, i concetti di bellezza, giustizia, amore, famiglia, amicizia, insomma tutti quei correlati e quei significati che connotano in maniera specifica un gruppo umano. [...] Possiamo quindi parlare di cultura nazionale (italiana, inglese ecc.), di cultura etnica (ladina, gallese ecc.), di cultura panetnica (ad esempio araba), regionale (lombarda, provenzale ecc.), ma anche di cultura di genere (maschile, femminile, transgender), di orientamento sessuale (gay, lesbica, bisessuale), generazionale (ad esempio adolescenziale), di abilità fisica (ad esempio dei non vedenti), di classe socioeconomica, di retroterra educativo, di categoria professionale»91.
L'intersezionalità ci conquista così il vantaggio di poter riconoscere i singoli posizionamenti individuali, le appartenenze plurime e le identificazioni complesse e contraddittorie, senza obbligarli nel letto di Procuste costituito da identità gruppali discrete. Permette così la decostruzione delle categorie esplicitando - per fornire esempi grossolani ma chiari - che una migrante, madre single e disabile non occupa la stessa posizione di un migrante giovane e robusto o che Cécile Kyenge - oftalmologa di origine congolese, ex ministro della Repubblica e attualmente parlamentare europea - non vive la stessa condizione di un giovane albanese che si prostituisce nei pressi della Stazione Termini. Questo approccio spinge però a passare dal parlare di intercultura al discutere di complessi contesti eterogenei92.
L'approccio intersezionale risulta infatti fondamentale per leggere quelle dinamiche che risultano sfocate allo sguardo interculturale, come quelle che riguardano ad esempio le cosiddette seconde generazioni. Questi giovani, infatti, adottano spesso forme di acculturazione selettiva (scegliendo cioè di assumere solo alcuni tratti culturali della cultura di destinazione, e ovviamente anche di quella di origine) e si devono confrontare con processi di integrazione (sociale ed economica) subordinata nella società italiana. Un esempio chiarificatore di questo loro trovarsi in bilico tra il rischio dell'esclusione e quello dell'assimilazione può essere quello delle seconde generazioni che vivano una condizione omosessuale o transgender, che possono trovarsi doppiamente «stranieri» (nella comunità d'origine e in quella lgbt) o costretti a rinunciare a parti di sé pur di integrarsi almeno in un gruppo93.
La fertilità di un approccio intersezionale si evidenzia però anche nel campo della produzione simbolica, come si mostra nell'analisi - ad esempio - del genere cinematografico dei cosiddetti cinepanettoni, quei film natalizi che - dal 2000 - hanno ottenuto in Italia grande successo di pubblico e che sembrano ben esemplificare quella violenza epistemica che caratterizza, abbiamo visto, la condizione postcoloniale. L'analisi di O'Leary sottolinea infatti come i personaggi di queste commedie esprimano posizioni razziste (così come argomentazioni sessiste, omofobiche, abiliste e giovanilistiche) che proseguono i discorsi coloniali, in un processo in cui mascolinità, whiteness ed eterosessualità si rafforzano vicendevolmente94. La commedia natalizia viene così mostrata come uno dei tanti modi di costruzione dell'italianità grazie al fatto che i suoi personaggi maschili (con le loro marcate caratteristiche regionali) si contrappongono all'alterità (la donna nera, grassa e brutta che si interessa sessualmente ai personaggi interpretati da Cristian De Sica e da Massimo Ghini, i neri che indirizzano le loro attenzioni sodomitiche al personaggio di Massimo Boldi, etc.). Il cinepanettone, insomma, ingigantisce in forme carnascialesche - e quindi ambivalenti - dinamiche intersezionali, quotidiane e quasi invisibili, che presiedono alla continua costruzione di quell'identità italiana bianca (ma anche maschile, eterosessuale, di ceto elevato...) che vediamo rappresentata nei due italiani in vacanza a Rio, in Sudafrica, a Beverly-Hills, a New York, a Miami, in India o sul Nilo.
Ora, l'intercultura si è certo, e meritoriamente, sforzata di realizzare studi in cui si analizzassero insieme più differenze e le loro interazioni95. Nel suo complesso, tuttavia, essa si è assestata su un piano di astrazione generalizzante che prescindeva dai concreti attraversamenti tra le differenze. Oggi, l'intersezionalità sfida invece l'intercultura a occuparsi degli intrecci teorici tra razzismo, sessismo, eterosessimo, abilismo, giovanilismo, etc. con un approccio concreto e posizionato, che affronti i campi dell'immaginario e del simbolico, nel tentativo di stanare tutte le poliedriche forme di dominio leggibili all'interno di una complessa cornice postcoloniale.
Per una pedagogia postcoloniale
Queste cinque sfide che la mutata realtà sociale e culturale lancia all'intercultura spingono quest'ultima in direzione di una svolta postcoloniale, cioè verso una teorizzazione pedagogica che, pur facendo tesoro dell'ormai lunga riflessione sul tema dell'incontro tra le culture, investa la dimensione socio-politica, quella cognitiva e quella emotivo-relazionale in un'ottica emancipatoria che travalichi la strutturazione asimmetrica propria della gerarchizzazione coloniale. Questa esigenza non è per nulla nuova ma è già stata proposta nel panorama pedagogico italiano da più di un decennio96. E ormai molti pedagogisti - da Cambi a Pinto Minerva, da Portera a Fiorucci - hanno iniziato a fare esplicito riferimento a prospettive di ricerca di tipo postcoloniale97. Forse allora i tempi potrebbero essere maturi anche nel nostro Paese per un'impostazione interculturale capace - è la mia proposta - oltre che 1) di un recupero storico-culturale dell'esperienza coloniale (analizzandone il vissuto, da una parte e dall'altra), anche 2) di reintrodurre nel dibattito teorico il tema del razzismo (da quello «negato» a quello istituzionale), 3) di assumere una prospettiva genealogica e di decostruzione dell'identità etnoculturale tout court (anche di quella nazionale), 4) di prestare attenzione alle dinamiche transnazionali degli attuali movimenti migratori, 5) di riconoscere l'inesausta fertilità culturale che caratterizza ogni identificazioni individuale e di gruppo (sia nel campo intraculturale sia in quello interculturale), nonché 6) di riconoscere l'Altro come soggetto autonomo con cui dialogare (dal punto di vista politico e da quello culturale), 7) di accettare la natura intrinsecamente conflittuale del contatto culturale e 8) di tener conto della continua relazione intersezionale tra le differenze, al fine di dotarsi di quegli strumenti teorici di gestione nonviolenta dei conflitti di cui la nostra società ha bisogno.
Cesare Burgio, About the pain of interculturalism. Toward a postcolonial pedagogy
After a brief analysis of multiculturalism and interculturalism, the paper proposes a post-colonial turn in the Italian intercultural pedagogy, in order to accept the five theoretical challenges that a constantly changing world offers to us: 1) the importance of postcolonial studies, 2) a critic of the Italian whiteness, 3) the hypothesis of creativity (intracultural and intercultural), 4) the eminently conflictual contact between cultures, 5) the intersectional method.
1 A. Cozzo, Stranieri. Figure dell'Altro nella Grecia antica, Trapani, Di Girolamo, 2014.
2 Oliverio, L'inclusione interculturale come frontiera educativa, in M. Striano (a cura di), Pratiche educative per l' inclusione sociale, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 67-70.
3 M. Tarozzi, Mediazione linguistico-culturale nei contesti educativi, in G. Favaro, L. Luatti (a cura di), L' intercultura dalla A alla Z, Milano, Franco Angeli, 2004.
4 A. Palumbo, Diritti di gruppo e autonomia politica. Una prospettiva arendtiana sulla crisi del multiculturalismo liberale, in A. Palumbo, V. Segreto (a cura di), Globalizzazione e governance delle società multiculturali, Milano-Udine, Mimesis, 2011, p. 167.
5 V. Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, Milano, Vita e Pensiero, 2000, p. 119.
6 A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, Milano, Raffaello Cortina, 2002, p. 45.
7 W. Kymlicka, Il multiculturalismo e le accuse di essenzialismo: teorie, politiche, ethos, in A. Palumbo, V. Segreto (a cura di), Globalizzazione e governance delle società multiculturali, cit., p. 41.
8 A. Palumbo, Diritti di gruppo e autonomia politica , cit., pp. 141-2.
9 C. Sirna Terranova, Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte, Milano, Guerini e Associati, 1997, p. 45.
10 G. Burgio, I tamil e gli altri migranti. Sincretismo e intercultura a Palermo, in E. Pace (a cura di), Le religioni nell'Italia che cambia, Roma, Carocci, 2013, pp. 207-214.
11 G. Campani, Dinamiche identitarie ed interculturalità, in G. Campani, Z. Lapov (a cura di), Dinamiche identitarie: multilinguismo ed educazione interculturale, Torino, L'Harmattan Italia, 2001, p. 44.
12 C. Sirna Terranova, Pedagogia interculturale, cit., p. 34.
13 J. Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 42.
14 L. Tikly, Education and the New Imperialism, in «Comparative Education», Vol. 40, No. 2, May 2004, pp. 173-198.
15 C. Sirna Terranova, Pedagogia interculturale, cit., p. 23.
16 Ivi, p. 24.
17 Ivi, p. 38.
18 F. Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, Roma, Carocci, 2001; F. Pinto Minerva, L'intercultura, Roma-Bari, Laterza, 2002; M. Tarozzi, Dall'intercultura alla giustizia sociale. Per un progetto pedagogico e politico di citadinanza globale, Milano, Franco Angeli, 2015.
19 S. Ponzanesi, La 'svolta' postcoloniale negli Studi italiani. Prospettive europee, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, Firenze, Le Monnier, 2014, p. 50.
20 E. W. Said, Culture and Imperialism, London, Vintage, 1993, pp. 33-4.
21 G. Burgio, Colonie, Imperi e Migrazioni. Un inquadramento postcoloniale dell'Europa multiculturale, in «Educazione. Giornale di pedagogia critica», anno I, n. 2, Luglio-Dicembre 2012, pp. 65-88.
22 S. Ponzanesi, La 'svolta' postcoloniale negli Studi italiani, cit., p. 51.
23 R.F. Betts, La decolonizzazione, Bologna, il Mulino, 2007, p. 90.
24 E. Zucchetti, Un mercato del lavoro plurale: tra «vecchi» e «nuovi» equilibri, in S. Bertolini, R. Rizza (a cura di), Atipici?, Milano, FrancoAngeli, 2005, p. 31.
25 M. Mellino, Buenos Aires 2001 - Tunisi 2011, la fine di una lunga notte in dieci anni, in A. Pirri (a cura di), Libeccio d'Oltremare. Il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all'Occidente, Roma, Ediesse, 2011, p. 73.
26 S. Mezzadra, La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale, Verona, Ombre Corte, 2008.
27 S. Ponzanesi, La 'svolta' postcoloniale negli Studi italiani, cit., pp. 48-9.
28 Ivi, p. 64.
29 C. Clò, Hip pop all'italiana. L'immaginazione postcoloniale delle seconde generazioni, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, cit., p. 251.
30 C. Lombardi-Diop, C. Romeo, Il postcoloniale italiano. Costruzione di un paradigma, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, cit., p. 11.
31 S. Mezzadra, M. Ricciardi, Introduzione, in S. Mezzadra, M. Ricciardi (a cura di), Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche, Verona, Ombre Corte, 2013, p. 22.
32 A. Gorz, Perché la società del lavoro salariato ha bisogno di nuovi servi?, in AA.VV. Nuove servitù, Roma, Manifestolibri, 1994.
33 D. Harvey, L'enigma del capitale. E il prezzo della sua sopravvivenza, Milano, Feltrinelli, 2011.
34 V. Lanternari, Antropologia e imperialismo, Torino, Einaudi, 1974, p. 375.
35 R. Sennett, Autorità. Subordinazione e insubordinazione: l'ambiguo vincolo tra il forte e il debole, Milano, Bruno Mondadori, 2006, p. 27.
36 S. Marcenò, Modelli di integrazione dei migranti tra emancipazione e subalternità. Il caso degli ebrei etiopi in Israele, in A. Palumbo, V. Segreto (a cura di), Globalizzazione e governance delle società multiculturali, cit., p. 230.
37 S. Ponzanesi, La 'svolta' postcoloniale negli Studi italiani, cit., pp. 64-5.
38 R.N. Welch, Razza e (ri)produttività. Per una lettura biopolitica della razza nell'Italia postunitaria e contemporanea, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, cit., p. 83.
39 J. Guglielmo, S. Salerno (a cura di), Gli italiani sono bianchi? Come l'America ha costruito la razza, Milano, il Saggiatore, 2006.
40 C. Lombardi-Diop, C. Romeo, Il postcoloniale italiano, cit., p. 4.
41 R.N. Welch, Razza e (ri)produttività, cit., p. 77.
42 Ivi, p. 81.
43 C. Lombardi-Diop, C. Romeo, Il postcoloniale italiano, cit., p. 15.
44 S. Di Matteo, Quando il Sud fece l'Italia. Fatti e misfatti dell'Unità, Roma, Arbor, 2011.
45 M.A. Pirrone, La Sicilia tra frontiera della periferia e periferia essa stessa, in C. Bartoli (a cura di), Asilo/esilio. Donne migranti e richiedenti asilo in Sicilia, Palermo, Duepunti, 2010, pp. 32-62.
46 C. Lombardi-Diop, Postcoloniale/postrazziale. Riflessioni sulla bianchezza degli italiani, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, cit., p. 168.
47 C. Romeo, Evaporazioni. Costruzioni di razza e nerezza nella letteratura postcoloniale afroitaliana, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, cit., p. 207.
48 C. Lombardi-Diop, Postcoloniale/postrazziale, cit., p. 167.
49 M. Ambrosini, Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, Bologna, il Mulino, 2008.
50 G. Burgio, L' identità diasporica. Pratiche transnazionali e dinamiche interculturali, in Id. (a cura di), Oltre la nazione. Conflitti postcoloniali e pratiche interculturali. Il caso della diaspora tamil, Roma, Ediesse, 2014.
51 C. Clò, Hip pop all'italiana, cit., p. 251.
52 A. Portelli, 'Roma forestiera'. Musiche migranti e nuova musica popolare urbana, in C. Lombardi-Diop, C. Romeo (a cura di), L'Italia postcoloniale, cit., p. 244.
53 E. Santoro, Democrazia, migrazioni e società multiculturali, in S. Mezzadra, M. Ricciardi (a cura di), Movimenti indisciplinati, cit., p. 147.
54 Ivi, p. 148.
55 V. Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, cit., p. 142.
56 A. Favole, Cultura, creatività, potere. Un'introduzione al Manifesto di Losanna, in F. Saillant, M. Kilani, F. Graezer Bideau (a cura di), Per un'antropologia non egemonica. Il Manifesto di Losanna, Milano, Elèuthera, 2012, pp. 12-14.
57 A. Favole, Creatività culturale, in F. Saillant, M. Kilani, F. Graezer Bideau (a cura di), Per un'antropologia non egemonica, cit., p. 64.
58 Ivi, p. 63.
59 D. Chakrabarty, L'artificio della storia, in C. Pasquinelli (a cura di), Occidentalismi, Roma, Carocci, 2005, p. 58.
60 S. Borutti, U. Fabietti, Scrivere l'assente, introduzione a M. de Certeau, La scrittura dell'altro, Milano, Cortina, 2005, p. XIII.
61 M. de Certeau, La scrittura dell'altro, cit., p. 76.
62 Ivi, p. 30.
63 Ivi, pp. 35-6.
64 Tra questi va ovviamente posto anche il sottoscritto che, mentre scrive queste affermazioni, non fa - in fondo - che prolungare un atteggiamento di presa della parola (anche) al posto dell'Altro.
65 S. Oliverio, L'inclusione interculturale come frontiera educativa, cit., p. 56.
66 M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, Roma, Donzelli, 1996.
67 M. Ricca, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari, Dedalo, 2008.
68 M. Mellino, La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies, Roma, Meltemi, 2005, p. 80.
69 J. d'Adesky, Subalternità, in F. Saillant, M. Kilani, F. Graezer Bideau (a cura di), Per un'antropologia non egemonica, cit., pp. 132-3.
70 F. Oliveri, Lotte dei migranti ai confini della cittadinanza: una proposta teorico-metodologica, in M. Omizzolo, P. Sodano (a cura di), Migranti e territori. Saggi e ricerche di sociologia delle migrazioni, Roma, Ediesse, 2015, pp. 133-158.
71 M. Tomba, Da Honneth a Hegel. Multiculturalismo e riconoscimento, in A. Palumbo, V. Segreto (a cura di), Globalizzazione e governance delle società multiculturali, cit., p. 125.
72 L. Lo Schiavo, Sfera pubblica, giovani migranti, intersezionalità: alcuni elementi di analisi, in «Quaderni di Intercultura», Anno III/2011, DOI 10.3271/A17, p. 3.
73 S. Palidda, Escalation della guerra permanente, in «Alfabeta2» del 16/11/2015, disponibile on line (http://www.alfabeta2.it/2015/11/16/guerra-permanente/, ultima consultazione 25 novembre 2015).
74 A. Pirri, Il corpo della nazione. Sessismo e razzismo nella genesi del nazionalismo, in G. Burgio (a cura di), Oltre la nazione, cit., p. 184.
75 B. Anderson, Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri, 2000.
76 A. Pirri, Il corpo della nazione, cit., p. 185.
77 Ivi, p. 186.
78 Ivi, pp. 206-211.
79 bell hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 37-8.
80 S. Sabelli, Sessualità, razza, classe e migrazioni nella costruzione dell' italianità, in F.M. Cacciatore, G. Mocchi, S. Plastina (a cura di), Percorsi di genere. Letteratura, Filosofia, Studi postcoloniali, Milano-Udine, Mimesis, 2012, p. 141.
81 G. Stefani, Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere, Verona, Ombre Corte, 2007, p. 97.
82 Ivi, p. 45.
83 N. Poidimani, Difendere la 'razza'. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini, Roma, Sensibili alle foglie, 2009.
84 S. Sabelli, Sessualità, razza, classe e migrazioni nella costruzione dell'italianità, cit., p. 146.
85 Ivi, p. 140.
86 A. Rivera, La Bella, la Bestia e l'Umano. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo, Roma, Ediesse, 2010.
87 S. Marchetti, Intersezionalità, in C. Botti (a cura di), Le etiche della diversità culturale, Firenze, Le Lettere, 2013, pp. 133-4.
88 L. McCall, The Complexity of Intersectionality, in «Signs», vol. 30, n. 3, 2005, pp. 1771-1800.
89 M. Pasquino, S. Sabelli, Femminismo e femminismi dagli anni Ottanta al XXI secolo, in M.S. Sapegno (a cura di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, Milano, Mondadori, 2011, pp. 179-195.
90 D. Zoletto, Ricerca pedagogica e prospettive postcoloniali, in AA.VV., Postcolonial studies in Italy, disponibile online (http://www.postcolonialitalia.it/index.php?option=com_content& view=article&id=67:ricerca-pedagogica-e-prospettive-postcoloniali&catid=27:interventi&It emid=101&lang=it, ultima consultazione 24 novembre 2015).
91 I. Castiglioni, La comunicazione interculturale: competenze e pratiche, Roma, Carocci, 2013, pp. 42-3.
92 D. Zoletto, Dall'intercultura ai contesti eterogenei. Presupporti teorici e ambiti di ricerca pedagogica, Milano, Franco Angeli, 2012.
93 G. Burgio, Desideri sconfinati. Sessualità migranti e frontiere culturali, in M. Durst, C. Roverselli (a cura di), Gender/genere. Contro vecchie e nuove esclusioni, Pisa, ETS, 2015, pp. 15-36.
94 A. O'Leary, Mascolinità e bianchezza nel cinepanettone, in G. Giuliani (a cura di), Il colore della nazione, Firenze, Le Monnier, 2015, pp. 76 e 86.
95 Per tutti, si veda F. Cambi, G. Campani, S. Ulivieri (a cura di), Donne migranti. Verso nuovi percorsi formativi, Pisa, ETS, 2003.
96 C. Sirna, Postcolonial education e società multiculturali, Lecce, Pensa Multimedia, 2003.
97 D. Zoletto, Ricerca pedagogica e prospettive postcoloniali, cit.
Giuseppe Burgio
Esperto di pedagogia
You have requested "on-the-fly" machine translation of selected content from our databases. This functionality is provided solely for your convenience and is in no way intended to replace human translation. Show full disclaimer
Neither ProQuest nor its licensors make any representations or warranties with respect to the translations. The translations are automatically generated "AS IS" and "AS AVAILABLE" and are not retained in our systems. PROQUEST AND ITS LICENSORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES FOR AVAILABILITY, ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, NON-INFRINGMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Your use of the translations is subject to all use restrictions contained in your Electronic Products License Agreement and by using the translation functionality you agree to forgo any and all claims against ProQuest or its licensors for your use of the translation functionality and any output derived there from. Hide full disclaimer
Copyright Firenze University Press 2015
Abstract
After a brief analysis of multiculturalism and interculturalism, the paper proposes a post-colonial turn in the Italian intercultural pedagogy, in order to accept the five theoretical challenges that a constantly changing world offers to us: 1) the importance of postcolonial studies, 2) a critic of the Italian whiteness, 3) the hypothesis of creativity (intracultural and intercultural), 4) the eminently conflictual contact between cultures, 5) the intersectional method.
You have requested "on-the-fly" machine translation of selected content from our databases. This functionality is provided solely for your convenience and is in no way intended to replace human translation. Show full disclaimer
Neither ProQuest nor its licensors make any representations or warranties with respect to the translations. The translations are automatically generated "AS IS" and "AS AVAILABLE" and are not retained in our systems. PROQUEST AND ITS LICENSORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES FOR AVAILABILITY, ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, NON-INFRINGMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Your use of the translations is subject to all use restrictions contained in your Electronic Products License Agreement and by using the translation functionality you agree to forgo any and all claims against ProQuest or its licensors for your use of the translation functionality and any output derived there from. Hide full disclaimer